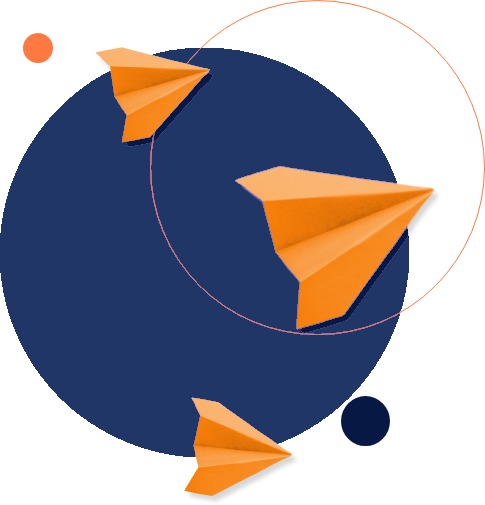FORMARSI PER INNOVARE
Invito 1/2025
In attuazione del Fondo Nuove Competenze 3 e per le aziende di nuova adesione
RISORSE INIZIALI STANZIATE:
LINEA FNC: 1.000.000 €
LINEA 8 JUST IN TIME: 1.500.000

FORMARSI PER INNOVARE
Invito 1/2024
La nuova offerta formativa di Fondartigianato per finanziare la formazione di imprese e lavoratori
STANZIAMENTO INIZIALE
26.000.000 €